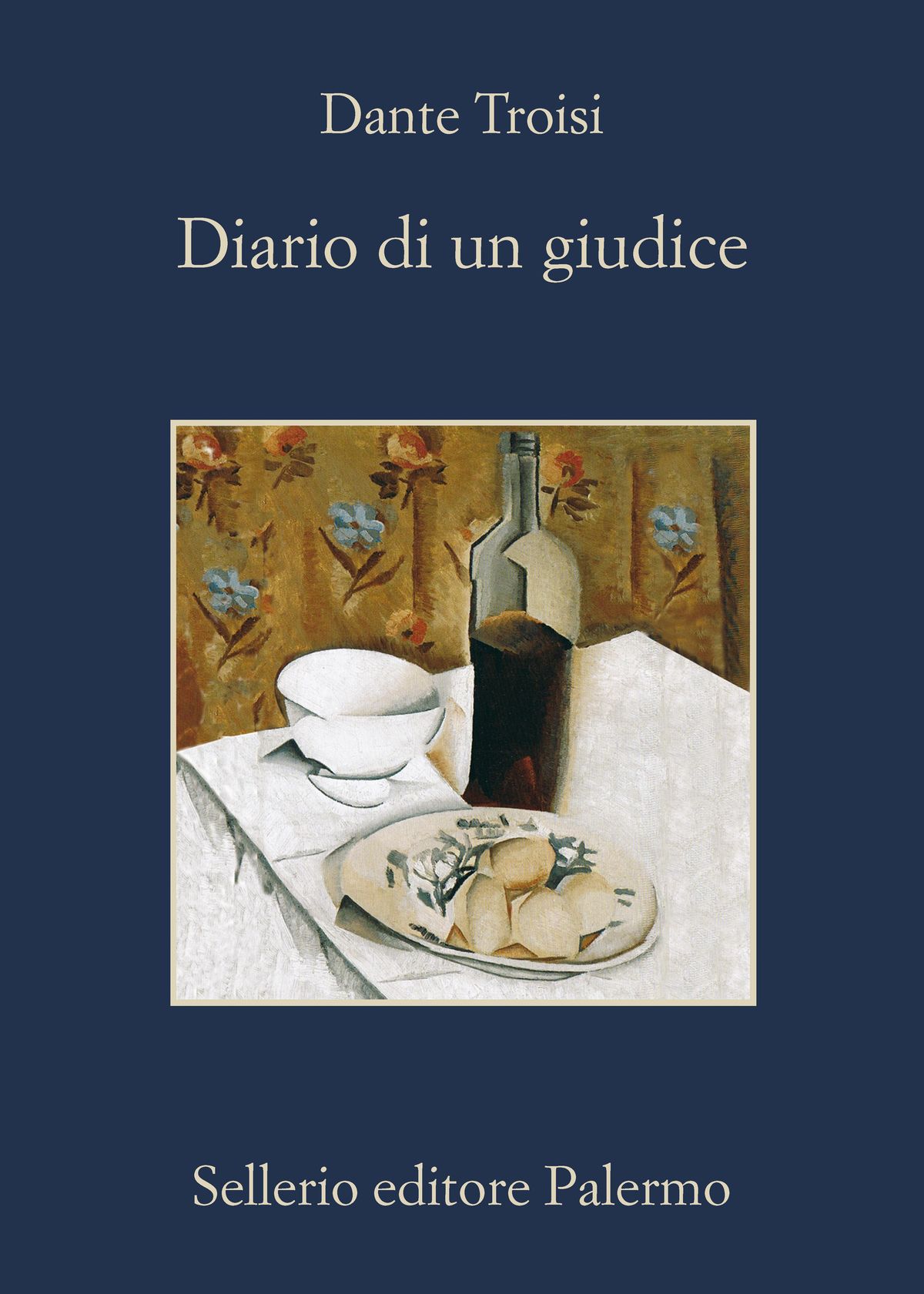Nel 1955 Einaudi pubblicò “Diario di un giudice” di Dante Troisi.
Il libro è ora di nuovo disponibile, edito da Sellerio.
https://www.sellerio.it/it/catalogo/Diario-Un-Giudice/Troisi/5076
L’autore, nato a Tufo, in provincia di Avellino, nel 1920, era stato, ventenne, prigioniero degli Alleati per sei anni, prima di tornare in Italia e diventare magistrato.
Le vicende che descrive nel libro, pur non direttamente localizzate nella geografia giudiziaria, sono riferibili al suo lavoro di giudice a Cassino: un tribunale “situato a metà strada tra due grandi città … sede di ripiego per chi non può andare nell’una o nell’altra”. Troisi ci rivela come la quasi totalità dei magistrati di quel tribunale non pensi che prestare servizio in una sede in cui si è vicini alle storie di vita dei cittadini possa essere nobile, come nessuno o quasi sembri rendersi conto del valore della Costituzione che vuole i magistrati distinti tra di loro solo per diversità di funzioni: la stagione dei pretori è di là da venire.
L’anelito del gruppo di magistrati che popola il libro è quello di “fare carriera” e mirabili sono le descrizioni da parte di Troisi delle piccolezze che ne derivano: il collega che gli dà ossequiosamente la destra perché è dietro di lui nella graduatoria del concorso; la frenetica consultazione del “ruolo di anzianità” per capire come conquistare un incarico direttivo.
Non a caso il libro si apre con l’insediamento di un nuovo presidente del tribunale, che esercita un atteggiamento paternalistico come “superiore” e si trova di fronte i tentativi di palesare devozione da parte degli “inferiori”.
La descrizione dei magistrati chinati e intimoriti, che Dante Troisi ci offre quasi in ogni pagina del suo libro, insieme al suo tentativo di vedersi invece come magistrato costituzionalmente orientato, sembrano attraversare il tempo e ci pongono di fronte al modello di magistrato omologato e gerarchicamente ossequiente che le cosiddette riforme della giustizia – in realtà rappezzi malriusciti di un ordinamento giudiziario sempre incerto rispetto alla forza, essa sì potentemente riformatrice, della Costituzione vigente – implicitamente o esplicitamente vorrebbero oggi suggerire.
Devasta quei magistrati (degli Anni ’50 del secolo scorso…) “una paura continua non già di non saper fare il giudice, ma di non riuscire gradito in qualche cosa al superiore”.
E la “comune sudditanza” non suggerisce solidarietà tra colleghi: “non v’è speranza che gli altri aiutino o siano clementi con uno di noi che sbaglia”; perché prevale il sentimento del “rischio di sentirsi addossata la stessa colpa”.
Vicende recenti testimoniano la contemporaneità di questa possibile deriva antropologica.
Nell’editoriale della Newsletter di Magistratura democratica del 17 luglio 2023, intitolato “L’onda di luglio”, con riferimento a opinabili decisioni del Csm in quel periodo, si legge: “i magistrati ‘bravi’ – che meritano di vivere tranquilli, di percorrere una ‘carriera’ e di coltivare i loro ‘sogni modesti’ (diceva Gianfranco Bertoli degli ossequienti ai padroni) – prevarranno sui magistrati ‘cattivi’, ostinati nel credere che fare il ‘mestiere della Costituzione e dei diritti’ significhi anche alzare la testa dalle carte e dedicare tempo, energie, intelligenza al mondo intorno a sé. Chi non dà fastidio e non si fa dare fastidio, chi sbriga le faccende, chi ha i numeri – formalmente – ‘a posto’ sarà ben valutato e accolto nei campi elisi in cui il prestigio della funzione ‘neutralissimamente’ esercitata accomuna agli (altri) potenti, al loro prestigio, ai loro privilegi”.
I limiti antropologici accettati e praticati dai magistrati descritti da Troisi, la gerarchia, i residui di fascismo nell’Italia del dopoguerra, l’esercizio dei poteri polizieschi, erano i fattori condizionanti quella remota magistratura.
“Ogni giorno si discute della carriera, che via via passano gli anni è la preoccupazione dominante: passano gli anni e diminuisce il coraggio che spesso è inversamente proporzionato al grado. Lentamente si diventa quasi tutti burocrati, specialisti, e l’ufficio è la piazza d’arme in cui sta per arrivare il comandante: il comandante controlla se le scarpe sono pulite, il vestito stirato, la faccia senza segni di barba… si bada al quieto vivere, al non aver fastidi per avanzare nella gerarchia”.
C’è, in questa terribile descrizione della mancanza di senso del lavoro di magistrato, un barlume di speranza: i giovani magistrati – come era Troisi – possono rifiutare queste logiche riduttive; lo faranno, in forma organica, qualche anno dopo la pubblicazione del libro, nel 1964, i fondatori di Magistratura democratica, lo possono fare oggi i più giovani che hanno scelto il sacrificio del concorso e il peso dell’avvio della loro presenza in magistratura, per essere al servizio dei cittadini, per essere soggetti solo alla Costituzione e alle leggi, non per trovarsi “a posto con i numeri” come la perniciosa deriva degli obiettivi da Pnrr sembra imporre, con un filo rosso che lega interventi normativi ad ansie dei “capi”; non per anelare alla protezione di potenti (o sedicenti tali) interni o esterni alla magistratura, sperando di arrivare in futuro a condividere un pezzetto irrisorio di quel potere. Essendo invece, come si legge nella lettera del Segretario di Md pubblicata nella Newsletter del 23 dicembre 2024, “impegnati a dare prospettiva e speranza alla giurisdizione costituzionalmente orientata, in nome della quale hanno affrontato gli studi, il concorso” e vivono i primi difficili anni di servizio.
E non solo i più giovani ma tutti insieme: essere magistrati, senza bisogno di esercitarsi in “vuote e retoriche espressioni di omaggio”, senza bisogno di manifestare “devozione e meticolosità” nello smaltimento dei fascicoli: quel ridurre a ben poco la magistratura, che Dante Troisi, con quelle parole e con l’intero suo racconto, mette in luce. Settanta anni orsono come oggi.